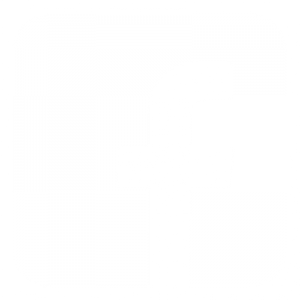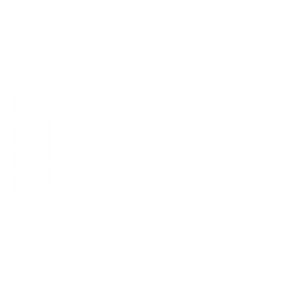Chiara Pedroli, fisioterapista.

Le parole sono importanti, diceva rabbioso Nanni Moretti nel suo Palombella Rossa: le parole sono importanti. Ed è importante sceglierle, è importante ascoltarle e farle proprie, è importante usarle bene. E c’è una parola che torna spesso, nella chiacchierata con Chiara Pedroli – fisioterapista presso il nostro centro – e questa parola è “cura”. Ecco, ricordiamola questa parola: la troveremo tra un po’, e spiegherà tutto.
Una di quelle chiacchierate che iniziano e poi prendono la strada che vogliono, sotto un sole ancora caldo a dispetto di un autunno già inoltrato e buttando di tanto in tanto un occhio alla carrozzina dove Fabio, un mese compiuto da poco, dorme beatamente. E si parte proprio da lì, da quel miracolo addormentato: perché il piccolo Fabio è l’ultimo di sei figli e perché Chiara oltre a essere una fisioterapista è anche la mamma di una famiglia numerosa. “E infatti – racconta – io credo di fare due lavori: entrambi bellissimi, entrambi impegnativi, entrambi a tempo pieno. Le mie giornate passano per continue combinazioni e incastri tra i miei due lavori. La mamma, la fisioterapista”.
Ecco, parliamone un po’. Com’è nata l’idea di diventare quello che è diventata?
Diciamo che il caso, e le sorprese che la vita ti sa riservare, ci hanno messo del loro. Io facevo il liceo classico e alla fisioterapia non ci pensavo: mi sarebbe piaciuto lavorare in ambito sanitario ma non volevo fare il medico, e soprattutto avevo il sogno di dare vita a una famiglia numerosa, volevo fare la mamma. Finito il liceo, un po’ per curiosità e un po’ per scommessa, mi sono iscritta al test di ingresso per entrare a fisioterapia: i posti erano pochi e le domande erano molte quindi non ci avevo fatto molto affidamento, e l’alternativa sarebbe stata quella di iscrivermi a lettere classiche per poi andare, chissà, a insegnare.
E invece…?
E invece, ho superato il test di ingresso. E credo sia stato soprattutto merito del mio voto di maturità che era molto alto e ha fatto la differenza: ecco, allora il voto di maturità contava ancora. In una di quelle “sliding doors” della vita, ho iniziato il mio percorso in questo mondo che per me era completamente nuovo.
E che percorso è stato?
Posso riassumerlo in due parole: imparare, facendo. Tante informazioni, tanta base, tante nozioni: ma soprattutto, tanta pratica perché questo è un lavoro in cui bisogna “fare”. Non è possibile parlare di fisioterapia in senso generale, perché si tratta di un universo troppo vasto: sempre più, si deve parlare di specializzazione. Perché sono e saranno sempre tantissime le diversità che ci si trova a dover affrontare: non siamo tuttologi, non possiamo trattare allo stesso modo la fisioterapia infantile e quella ortopedica, la fisioterapia neurologica e quella dell’età evolutiva.
E quindi?
Quindi, lo studio che dà una base generale è fondamentale. Ma poi c’è il campo, ed è sul campo che si impara davvero.
E il campo di Chiara, qual è stato?
Dopo la laurea, per una decina d’anni ho lavorato alle Terrazze: ed è lì che ho imparato quello che so fare, ho imparato il mio lavoro.
Raccontiamolo, quel periodo.
La struttura si occupa di riabilitazione dell’età adulta, di pazienti con traumi o danni neurologici. Si lavora con la continua e costante presenza del medico, quindi l’operatività è molto divisa per competenze: il fisioterapista sa fin dove deve arrivare, sa quello che spetta a lui e quello che invece spetta al medico. Poi, si lavora come una squadra: con un confronto continuo, con la condivisione delle decisioni e con un dialogo costante. Ed è questa la vera, grande differenza rispetto alla libera professione: qui c’è ovviamente molta più autonomia che da un lato è estremamente affascinante e gratificante, dall’altro riserva molte più responsabilità.
E come è arrivata alla libera professione?
Carlo, una persona che conoscevo e stimavo da tempo, mi ha proposto di collaborare con lo studio Olos: io all’epoca avevo un figlio solo, quindi mi sono lanciata e inizialmente ho portato avanti entrambi i lavori. Stavo alle Terrazze a Cunardo, poi appena staccavo andavo in Olos: pochissimo tempo libero, orari pesantissimi, ma tanta soddisfazione. Poi…
Poi?
Poi i figli sono diventati due, poi tre, poi quattro… E, no: tutto non poteva starci. E quindi, ho scelto Olos. E non avrei potuto fare una scelta migliore.
Perché?
Perché questo centro, lo sento molto mio. E perché io sono fatta così: il paziente, la sua storia, il suo percorso. Tutto questo mi coinvolge, mi entra dentro, mi prende. Lo so, lo so che quelli “bravi” dicono che non si dovrebbe. Lo so che questo rende tutto più difficile perché quando ero a Cunardo e uno dei miei pazienti moriva, io stavo male e piangevo: e voglio che sia così, voglio che questo coinvolgimento rimanga, voglio che il mio stare male di fronte a una morte o a un problema non passi mai. Non c’è un modo diverso per fare questo mestiere.
Ecco, spieghiamola questa cosa…
Ruota tutto attorno alla parola cura. Noi curiamo, ecco: ma la parola “cura” dovremmo utilizzarla per quello che realmente significa. Non è possibile prendersi cura di una persona senza essere emotivamente coinvolti, senza essere collegati con quella persona: l’empatia è il cardine di una buona presa in carico del paziente, di una buona cura. Perché prendersi cura di una persona significa accettare di fare un pezzo di strada insieme, significa gioire per ogni piccolo traguardo, e significa anche soffrire per ogni passo indietro e per ogni sconfitta.
Certo, così diventa più difficile?
Ma non c’è un’altra strada: non c’è un altro modo. Mi “porto il lavoro a casa”? Sì, certo. Così come i miei pazienti si portano a casa le loro difficoltà e le loro sofferenze: non timbro il cartellino, non lavoro in una catena di montaggio. Lavoro con persone, generalmente con persone che soffrono: e la cura passa dal dialogo, passa dalla condivisione. Si fa più fatica? Certo. Si soffre? Spesso. Ma non c’è un modo differente di fare questo lavoro.
Facciamo qualche esempio?
La signora malata di SLA che purtroppo peggiora di giorno in giorno e che ora con la situazione legata al Covid non può più venire: ecco, pensare a lei mi fa stringere il cuore perché abbiamo interrotto una strada che avevamo iniziato insieme. O quel signore paraplegico che ha voluto a tutti i costi provare a fare riabilitazione nella nostra piscina e ha iniziato un viaggio splendido: fatto di piccoli progressi, di battaglie vinte che lo hanno portato a fare qualche metro a nuoto. Cammina? No. Camminerà mai? No. Ma quei due metri fatti nella piscina sono come la traversata della Manica. E con questo paziente io ci lavoro, ci vivo: sto in acqua con lui, lo aiuto a cambiarsi, condivido ogni fatica e ogni progresso. Lo curo, e spiegatemi voi come potrei curarlo senza essere coinvolta emotivamente nella sua storia. Curare è questo: è fare la fisioterapia, ma è anche ascoltare e parlare.
Parlare. Questo è un punto importante. Quanto conta “parlare bene”, in questo mestiere?
Torniamo a quella parola, alla parola “cura”: ecco, qui dentro c’è anche la capacità di comunicare, di utilizzare le parole giuste. Perché una parola giusta o sbagliata possono fare la differenza come una medicina giusta o sbagliata, perché serve comprendere la persona che hai di fronte per poter scegliere le parole da utilizzare. Ho visto ragazze piangere perché di fronte a una scoliosi complessa era stata usata la parola “deformità”, ho visto ragazzi chiudersi nel silenzio di fronte all’espressione “postura orribile”. No. Bisogna ricordare sempre che una parola può cambiare molto: un paziente può essere rassicurato, a un paziente si può spiegare come e quando risolverà il suo problema, e a quelli che invece purtroppo non lo risolveranno andranno dette parole di conforto e di aiuto. Queste cose non le insegnano all’università, ma sono troppo importanti.
Ecco! Ecco che Fabio si è svegliato mentre al telefono il primogenito (che va alle medie) richiede la sua dose di attenzioni. Ecco che Chiara ora si deve dedicare all’altro lavoro: quello della mamma.
Sono una donna fortunata: vengo al lavoro a piedi, il mio capo è un amico, ho un marito che è uno splendido padre e che anche se è sempre fuori per lavoro sa essere presente. Si può fare: si può essere mamma, anche mamma di sei figli, e allo stesso tempo una donna realizzata sul lavoro. Si può fare, perché una vita così è piena di cose belle: no, non ci si annoia mai. E si apprezza tanto, quando c’è, il silenzio.